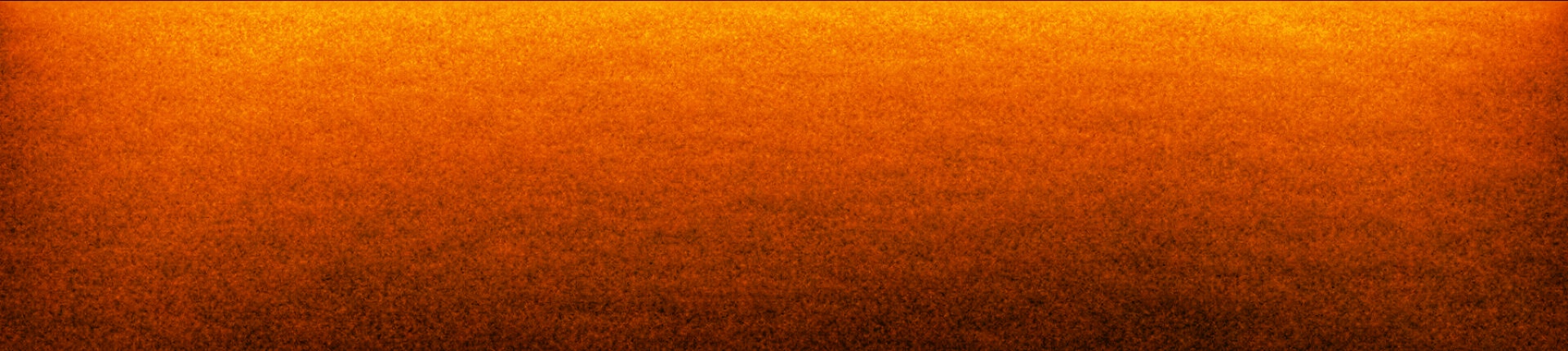Linguaggi e identità o della trasmigrazione
Di Mari Catricalà
La lingua e la sintassi della Straniera di Claudia Durastanti sono vulcaniche, nel senso di esplosive e anche di laviche. Tutta la mia esperienza del libro è stata assistere e partecipare a un’eruzione di temi e di parole continua, con sovrapposizioni, sostituzioni, passaggi fluidi o anche bruschi da un elemento ad un altro. Il racconto del rapporto con i genitori innesca le riflessioni sulla violenza, sull’amore e sulla disabilità; quello degli spostamenti geografici apre le porte alle questioni della letteratura, della musica, delle traduzioni e, più in generale, dei passaggi tra le lingue, con gli inevitabili errori e/o neologismi involontari. A volte, tutti questi temi esplodono sulla pagina, altre invece emergono e scorrono l’uno sull’altro, rinnovandosi sempre e creando nuovi itinerari a partire dagli stessi tracciati.
Credo che ogni esperienza di lettura sia anzitutto un’esperienza emotiva e che, in quanto tale, sia spesso una questione di riconoscimenti o, viceversa, di riconoscimenti mancati.
La prima volta che ho letto La straniera non penso di essere riuscita a cogliere molto del magma in cui mi trovavo ad annaspare (annaspare proprio, perché la sensazione era esattamente quella), ma ricordo distintamente di aver provato tante emozioni confuse e di essermi riconosciuta moltissimo. Ho ritrovato le storie delle migrazioni che non conoscevo e le musiche che non sapevo di amare e soprattutto ho riscoperto le transizioni linguistiche che mi ero dimenticata di operare sistematicamente sin da piccola. Le migrazioni dei miei genitori mi sono ancora perlopiù ignote, ma i passaggi da una lingua ad un’altra hanno caratterizzato e caratterizzano tuttora la mia realtà quotidiana. Si trattava solo di prenderli in considerazione attraverso una lente diversa, non abituale: quella delle parole di un romanzo autobiografico.
I giochi con il linguaggio e le riflessioni sul linguaggio tornano in continuazione nelle pagine della Straniera. Attraverso il linguaggio la narratrice sonda le proprie appartenenze culturali e delinea una parte della sua identità. Seguendola in questi percorsi ho notato quanto, anche nel mio caso e nel caso di altre persone che conosco che hanno vissuto esperienze analoghe di migrazione o anche solo di interlinguismo, i linguaggi a cui siamo abituati e che usiamo plasmino il nostro modo di interagire con le persone e con il mondo in generale.
Quando Claudia Durastanti scrive, nel suo libro, a proposito del suo arrivo in Basilicata dopo i primi sei anni di vita trascorsi a Brooklyn: «Ho imparato a leggere e scrivere in italiano, ma la mia lingua conteneva sempre un margine di errore che faceva ridere gli insegnanti», rende conto della difficoltà di traslare da una lingua a un’altra e della confusione che si crea nel mezzo. E non è un caso che il termine «errore» ritorni anche quando parla delle traduzioni di Fernanda Pivano che si trovava a leggere da piccola e ad amare poi all’università – gli errori di cui Pivano costellava le sue traduzioni e che la stessa Durastanti confessa di continuare a fare nel suo lavoro di traduttrice, «perché nessun significato assume una forma stabile in me, e tutto quello che penso, e quello che poi dico, soffre nella trasmigrazione tra paesi diversi». Le parole sbagliate che si pronunciano quando si passa da una lingua a un’altra sono l’evidenza di quella transizione, le tracce dello sforzo che quei passaggi richiedono. Non sono errori necessari, certo, ma spesso occorrono; e non è detto che debbano essere corretti.
Ricordo, dopo le estati trascorse con i nonni in Giappone, il rientro in Italia a settembre, con gli scambi linguistici faticosissimi perché da piccola non riuscivo a distinguere subito l’italiano dal giapponese, e finivo sempre con il confonderli senza nemmeno accorgermene se non nel momento in cui i miei interlocutori mi guardavano tra lo stranito e il divertito. Nella trasmigrazione linguistica che vivevo, diventavo incapace di comunicare. Poi ho imparato a distinguere le lingue e a farmi capire, ma di errori e di sviste continuo a farne anche io.
Così quando vedo che alcune espressioni nella Straniera vengono riprese più volte, in contesti diversi, con significati leggermente diversi, penso che queste colate linguistiche siano probabilmente un tentativo di appropriarsi della lingua, che passa attraverso lievi cambiamenti di significato, come a voler verificare fino a che punto una stessa espressione possa essere flessa e adattata al proprio discorso. Se in mezzo esplodono errori, tanto di guadagnato per il gioco: significa poter utilizzare le schegge di quegli errori per creare altre espressioni e altri fraseggi.
La nostra identità, mi è venuto da pensare, probabilmente è proprio come – o qualcosa di molto simile a – la lingua dell’autobiografia di Claudia Durastanti: esplosiva e lavica, imprevedibile e fluida. Non che non possiamo o non riusciamo a trovare dei punti fermi, di tanto in tanto, che ci diano almeno la parvenza di essere qualcosa di solido; ma se le transizioni – e credo che ogni atto comunicativo, in qualsiasi linguaggio, sia un atto transitorio – sono ciò che ci collegano alle altre persone e alle altre cose, come possiamo davvero dire di essere sempre una cosa sola, un blocco compatto? Credo mi piaccia di più pensare che esistiamo, a mo’ di «spore», in quelle transizioni continue e che il linguaggio sia sì una «mutilazione», come dice Lorrie Moore, ma anche l’unica crepa attraverso cui far entrare l’altro da noi.
E se l’autrice recupera Marx violandolo, «“Quando tutto cade, indomito il coraggio resta”» che diventa «“Quando tutto cade, indomito l’amore resta”», perché non sostituire di nuovo la parola con “passaggio”? Quando tutto cade, indomito il passaggio resta. In questa trasmigrazione vedo molto dell’identità che si forma e sussiste.